Cercando dei documenti, trovo in un cassetto una lettera, inviata nei primi giorni del 1998 a mia mamma Rita da suo fratello, Dario, con allegato una favola. Si, proprio una storiella per bambini, che Dario aveva inventato per un suo nipotino. Ricordo che molte volte mia mamma mi aveva citato questo racconto, ne era stata molto favorevolmente colpita. E mi aveva raccontato anche di questo bambino "americano". Di mio zio ne avevo già citato l’articolo (clicca qui) e il libro (clicca qui) e a breve ci sarà ancora un post a lui dedicato.
La lettera è molto tenera e spontanea, poetica, a tratti formale (di quella formalità dal sapore antico) a tratti gioviale. "[…] dopo i tuoi suggerimenti e aggiustamenti e limando, limando, sembra sia venuta abbastanza bene, tanto che il mensile ESPERIENZA le la ha pubblicata."

Ecco la favola del "Lupo Malos":
Mi arriva da Boston un nipotino di quattro anni, Gabriele: padre italiano, medico ad Harvard, madre già architetto a Caracas e oggi casalinga. Bene. Appena arrivato dorme per quasi due giorni consecutivi (a seguito del fuso orario). Poi basta. Non c’è più verso di farlo addormentare, finché chiedo ai suoi genitori di farmi provare. Accordato. Prendo Gabriele in braccio dicendogli che gli avrei raccontato la favola del lupo cattivo (che lui chiamerà malos, dalla lingua venezuelana) e dell’orso buono. Mi avvio alla finestra e comincio. Non ci si crederà ma, dopo pochissimi minuti, si addormenta, e così tutte le sere seguenti per un mese intero. Alla fine bastano poche filastrocche ed è già nei sogni di Morfeo. Quando poi è venuta l’ora di ripartire voleva che andassi con lui per continuare a raccontargli la favola. Così siamo arrivati ad un accordo: gli avrei scritto la favola del lupo "malos" e sua madre gliel’avrebbe letta. La favola? Eccola. Giuseppe Rebolini, Genova. (Si, in realtà lo zio Dario si chiama Giuseppe, NotaDiFabio)
Una mattina Dario e Gabriele decidono di andare a caccia nel bosco. Gabriele arma il suo fucile turbo, nuovo fiammante, ad acqua bollente e Dario la sua doppietta modello 1939 con cartucce caricate a pallettoni di plastica (più per difendersi che per offendere). Poi, naturalmente, oltre all’armamento, preparano anche due robusti zaini da montagna con borracce piene di whisky-soda e Coca-cola, più una robusta scorta di Nutella e salame di Varzi. Dopo circa due ore di marcia eccoli arrivati nel terreno di caccia, cioè nel bosco. Un bosco fantastico, con querce e pini secolari che salgono con le cime verso il cielo, quasi imprendibili. Camminando così nel sottobosco, oltre ai rumori che procurano i loro passi, sentono in lontananza un vocio di suoni non ben definiti. Stanno un poco a sentire, poi decidono di proseguire, sperando di riuscire a capirne di più. Ad un certo punto però Gabriele (dall’orecchio fino) dice a Dario (mezzo sordo): «Attento! Mi pare di sentire un lupo malos». Detto fatto: appena Dario si volta per guardare alle sue spalle, vede a dieci passi di distanza un grosso lupo malos che digrigna i denti in un modo da non lasciare alcuna speranza. Così Dario imbraccia il fucile e spara: tam-tam, due colpi dritti e precisi nel sedere del lupo molos, il quale – sentendosi bruciacchiare la pellaccia – si ritira per qualche metro. Ma poi, avendo capito che oramai il pericolo era passato e che il fucile era scarico, ritorna sui suoi passi costringendo i due a ripiegare velocemente, alquanto spaventati, verso un grosso pino. Gabriele, agile e veloce, vi si arrampica con molta facilità salendo sino alle cime più alte, tanto in alto da sembrare "la piccola vedetta lombarda", mentre Dario – più lento e appesantito – si accontenta (ansimante) di conquistare le prime posizioni di sicurezza. Intanto il lupo malos si piazza ai piedi della grossa pianta digrignando sempre più quei lunghi denti, consapevole che prima o poi sarebbero dovuti scendere. E allora avrebbero sicuramente fatto i conti con lui. Dopo qualche ora di scomoda attesa, Gabriele con il suo giovanile entusiasmo e coraggio dice a Dario di voler scendere ad affrontare il lupo malos con il suo potente fucile "turbo" caricato ad acqua bollente. Ma mentre Dario, non troppo convinto dell’esito positivo dell’azione. discute con Gabriele, eccoti arrivare un grosso Orso Bruno. Una figura fantastica, grosso come una montagna, stupendo nella sua maestosa figura, che avanza con passi sicuri e cadenzati quasi a far tremare la terra sotto le sue zampe. E loro, lì, fermi quasi senza respiro.
Quando arriva sotto l’albero, stacca di colpo un grosso ramo e a mo’ di clava lo usa contro il lupo malos, il quale, capito al volo il pericolo, se la dà a gambe levate senza nemmeno voltarsi indietro. A questo punto incomincia una lunga "trattativa" con l’Orso Bruno: prima non ci si capisce, non è ben chiaro il suo linguaggio. Gabriele con la sua precoce cultura e le sue tre lingue straniere, prova con l’inglese. E da qualche cenno non sembra che capisca. Prova con lo spagnolo e qui va un poco meglio. Allora passa decisamente all’italiano. Ed è a questo punto che l’Orso Bruno si avvicina all’albero e, abbracciandolo come se volesse sradicarlo, dice: "Venite giù che sono vostro amico". E così, ancora un poco titubanti, Dario e Gabriele scendono dall’albero cominciando a scambiare qualche piccola frase di convenienza, tanto per tastare il terreno. Ma l’Orso Bruno li mette subito a loro agio dicendo che lui è amico del contadino che si trova dall’altra parte del bosco, dove va ogni notte a fare il "guardia-campo" contro i branchi di cinghiali affamati e devastatori. Dal contadino riceve in cambio le provviste per sfamare la propria famiglia. Così piano piano. seguendolo passo passo, i due arrivano nel bel mezzo del bosco dove, dietro una grande roccia, l’Orso ha la sua caverna-casa e cominciano le presentazioni. Mamma Orsa, stupendo esemplare di madre di famiglia, con fare dolce ma deciso, invita i due a entrare e a sedere. mentre tutto intorno è un incredibile brulicare di abitanti del bosco. Due belle gallinelle offrono un piattino di uova fresche che Mamma Orsa si appresta a mettere in tegamino, avendo capito al volo che il cacciatore più giovane, Gabriele, ha una fame da "lupi". Poi arriva il coniglio bianco, chiamato Ciuffetto, che comincia ad annusare le scarpe di Gabriele prima di saltargli in braccio e arrampicarsi su fino alla spalla; c’è pure il gattone bianco a chiazze nere, Micione, che dopo aver fatto una strusciata intorno alla gambe di Gabriele, si mette in un angolo appartato a russare. Arriva anche la volpe, Marianna, che avrebbe dovuto dare una mano a Mamma Orsa nel disbrigo delle faccende di casa, ma essendo furba come (appunto) una "volpe", si guarda bene dal fare qualcosa. Per non ripulire per terra o non lavare i piatti le studia sempre tutte: si fascia le zampe facendo finta di essere ferita, si trucca gli occhi con del carbone nero fingendosi ammalata. Ma nessuno oramai ci crede più. C’è pure Birbetto, lo scoiattolo rosso mattone con la sue lunga coda, sempre pronto a fare dispetti: come, per esempio, quello di portare via le scarpe a tutti di notte per nasconderle nell’albero cavo dove si è costruito una specie di dependance e dove si diverte un sacco a portare tutto quello che trova. Ogni tanto si becca anche qualche sculaccione da Mamma Orsa. Ma la prende sempre a ridere. Dopo aver conosciuto la famigliola di Orso Bruno e dopo che Mamma Orsa ha cucinato, tutti si siedono a tavola impeccabilmente serviti da Marianna, trasformatasi per l’occasione in una sorta di "Pippi calzelunghe", con i ciuffetti sparati in aria e con al centro un cappellino da fare invidia a quelli della Regina Elisabetta d’Inghilterra. Vuoi per l’appetito, vuoi per il gusto della nuova cucina, fatto sta che viene spazzato via tutto, compreso un barattolo di Nutella che Gabriele si è sentito in dovere di fare assaggiare ai nuovi amici. Anche il salame di Varzi sparisce in un attimo, soprattutto ad opera dell’Orso Bruno che sostiene di non averne mai mangiato di così buono. A questo punto, dopo i complimenti d’obbligo alla cuoca, vengono invitati gli altri animali del bosco a prendere il caffè e fare due chiacchiere alla buona prima di coricarsi. Arriva per prima la famiglia del tasso, con la moglie e le due figlie. L’Orso Bruno non si lascia allora scappare l’occasione di fare un benevolo rimprovero al tasso, che spesso si lascia attirare dal bel raccolto di granturco del contadino (amico dell’Orso Bruno) e ne approfitta a quattro ganasce costringendolo a fare una guardia così serrata al campo tanto da non potersi appisolare nemmeno un poco durante tutta la notte. Secondo ad arrivare è la famiglia dell’Orso Nero, anche questa composta da Mamma Orsa e due orsacchiotti neri, così lucidi e brillanti che sembrano dipinti dalla mano di un pittore con colori "Max Mayer". I due frugoletti si arrampicano in braccio a Gabriele leccandolo su tutto il collo e la faccia per dimostrargli la loro incondizionata amicizia. La serata passa così, veloce e felice; e dopo la prima ne passano altre, per circa una settimana… davvero indimenticabile. Sulla via del ritorno, Dario e Gabriele vanno adagio voltandosi a ogni passo. Già pensano alla prossima battuta di caccia che forse faranno in autunno. Ma intanto sono contenti, perché hanno vissuto un sogno permesso a pochi.

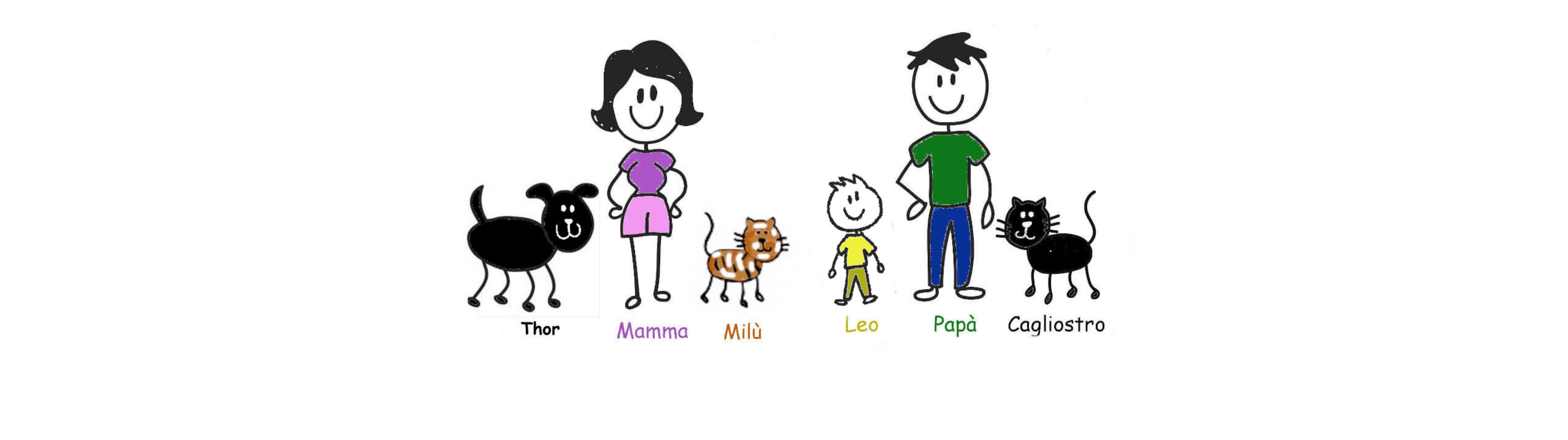






 Ma ora le cose sono cambiate, eravarno in due a provare questo strazio e ora sono solo, sono solo in questo 2008 che "lei" se ne è andata prima, ha voluto precedermi e salir lassù da sola, è andata su il diciannove aprile e non ha voluto aspettare il solito agosto.
Ma ora le cose sono cambiate, eravarno in due a provare questo strazio e ora sono solo, sono solo in questo 2008 che "lei" se ne è andata prima, ha voluto precedermi e salir lassù da sola, è andata su il diciannove aprile e non ha voluto aspettare il solito agosto.